Storia e preistoria della pesca a mosca
Sportelli Marco
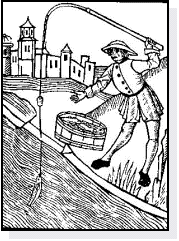 Da
tempo
si
disquisisce sulla zona d’origine e la paternità della pesca a mosca. C’è
chi la vuole in Inghilterra rifacendosi alla più antica pubblicazione
conosciuta sull’argomento
Treatyse of
fysshinge With an Angle, in cui Dama Juliana Berners, badessa a Sopewell,
nel 1496 descrive molto precisamente la pesca a mosca e diverse ricette di
mosche artificiali non molto dissimili da quelle che usiamo tuttora. Chi invece
la colloca in Macedonia ed ancora più lontano nel tempo avvalorandone
l’ipotesi con il dettagliato resoconto che Claudius Aelianus, nato nei pressi
di Roma nel 170 d.c., fa nel suo “ De Natura Animalium”. Racconta che nel
fiume Astraeus, nei pressi di Salonicco,
“i
Macedoni insidiano i pesci con astuzia avendo inventato per catturarli i
seguenti metodi: avvolgono l’amo con la lana rossa alla quale aggiungono due
piume che crescono sulla barba del gallo e che assomigliano al colore della
cera. La canna è lunga una klaftra (metri 1,96) e della stessa lunghezza è la
lenza. Lasciano galleggiare l’esca sull’acqua ed il pesce, attratto dal
colore e spinto dall’ingordigia, alla vista di tale succulento pasto, lo
ingoia e rimane attaccato all’amo per finire tragicamente”.
Da
tempo
si
disquisisce sulla zona d’origine e la paternità della pesca a mosca. C’è
chi la vuole in Inghilterra rifacendosi alla più antica pubblicazione
conosciuta sull’argomento
Treatyse of
fysshinge With an Angle, in cui Dama Juliana Berners, badessa a Sopewell,
nel 1496 descrive molto precisamente la pesca a mosca e diverse ricette di
mosche artificiali non molto dissimili da quelle che usiamo tuttora. Chi invece
la colloca in Macedonia ed ancora più lontano nel tempo avvalorandone
l’ipotesi con il dettagliato resoconto che Claudius Aelianus, nato nei pressi
di Roma nel 170 d.c., fa nel suo “ De Natura Animalium”. Racconta che nel
fiume Astraeus, nei pressi di Salonicco,
“i
Macedoni insidiano i pesci con astuzia avendo inventato per catturarli i
seguenti metodi: avvolgono l’amo con la lana rossa alla quale aggiungono due
piume che crescono sulla barba del gallo e che assomigliano al colore della
cera. La canna è lunga una klaftra (metri 1,96) e della stessa lunghezza è la
lenza. Lasciano galleggiare l’esca sull’acqua ed il pesce, attratto dal
colore e spinto dall’ingordigia, alla vista di tale succulento pasto, lo
ingoia e rimane attaccato all’amo per finire tragicamente”.
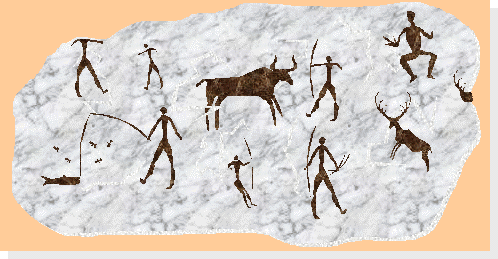
Ma la storia
non
smette mai di stupirci. La
pubblicazione scientifica tedesca “Die Lugner” riferisce che sono state
scoperte recentemente, nella zona di Postumia, già famosa per le sue grotte,
delle cavità naturali abitate dall’uomo nella preistoria. Sembra che
l’accesso fu occluso da una frana in tempi remoti e questa particolare
condizione ha permesso di conservare intatte fino ad ora delle stupende pitture
rupestri. Oltre alle usuali scene di caccia in una è chiaramente illustrato un
nostro progenitore nell’atto di procurarsi il cibo non con lancia od arco ma,
udite udite, con un attrezzo molto simile ad una canna da pesca cui è
chiaramente appeso tramite un filo un pesce. Ma questo non è tutto, difatti
analizzando attentamente l’elaborazione computerizzata di questa pittura,
eseguita dall’Istituto Lazljivac di Ljubljana risulta evidente l’intenzione
dell’arcaico artista di rappresentare nei pressi del pesce e del pescatore
delle farfalle o degli insetti, che se il pittore si è preso la briga di
raffigurare dovevano avere una notevole valenza nella scena. A noi fa piacere
pensare che quelle fossero mosche di Maggio, considerando che lì vicino scorre
da sempre il mitico UNEC, e che magari il nostro progenitore, usandole come
esca, ne costruisse anche di artificiali.
A
questo
punto
rimane solo da disquisire se pescasse secco o sommerso. La disputa tra
“puristi o meno” della mosca secca, che è viva tuttora, ha radici remote e
raggiunse probabilmente all’inizio del secolo, come riporta De Boisset, il suo
apice: “nella maggior parte di coloro
che erano in grado di servirsi di una canna da mosca, era presente, intangibile
e sacro, il
rispetto delle convenzioni
stabilite,
a guisa di regole ferree,
dalla scuola inglese dei “puristi” della mosca secca, di cui F.M. Halford fu
maestro autorevole e sovrano. Per essere considerati dei veri pescatori a mosca,
per essere ammessi al cenacolo dei “puri” che ricevevano la parola
d’ordine da Londra e gli esempi sulle rive dell’Hampshire, non era
sufficiente sapersi esprimere in inglese per parlare di pesca ma bisognava anche
accettare come articoli di fede tutte le regole promulgate dai maestri di scuola
britannica.”
All’egemonia Halfordiana si contrappose Skues che cercò di
rivalutare la mosca sommersa in quanto per lui non meno sportiva della secca. Le
polemiche tra questi due personaggi comunque proseguirono per anni, con un vasto
eco nella società del tempo, e crearono due schieramenti opposti.
Noi
non sappiamo se anche in tempi preistorici c’erano di queste dispute, comunque
proviamo ad immaginare che andò così:
NINFUS, giovane guerriero e valente cacciatore, avendo visto dei pesci nuotare nel fiume e salire spesso a ghermire grossi insetti, pensò di studiare un sistema per catturarli. Si rivolse a TUTAK-HODA, il saggio del villaggio, e ne ascoltò con attenzione i consigli. Il saggio era uno straniero, provenendo da un villaggio di pescatori ad almeno un chilometro di distanza, e purtroppo parlava un idioma tanto differente dal suo che NINFUS ebbe non poche difficoltà ad interpretare le sue parole, ma alla fine gli parve di capire che si, si potevano catturare quei pesci “ma fai attenzione, perché mangiano soprattutto sott’acqua!” gli disse il vecchio. Ricco di questi consigli si armò di clava e si tuffò per pescare sotto.

Ben presto però si accorse di quanto fosse urgente che qualcuno inventasse i sottotitoli. Perché la traduzione corretta, infatti, era: “ma soprattutto fai attenzione, perché se vai sott’acqua ti mangiano!”


KUL-DEKHA, suo fratello minore, era poco interessato alla caccia, prediligeva raccogliere frutti,bacche ed andare in cerca di nidi. Spesso si avvicinava al fiume perché le uova che preferiva erano quelle d’anatra, ed anche lui quindi, aveva notato da qualche tempo quei grossi pesci bollare.
Quella sera, tornando al villaggio,
raccolse un lungo ramo, leggero ed elastico. A casa lo aspettava sua moglie,
KHORT-LAND,
che non avendo figli ed essendo vanitosa dedicava tutto il suo tempo e le sue
attenzioni ai suoi lunghissimi capelli che seguendo la moda del tempo ungeva con
olio di lino. Ne era talmente fiera che se ne andava vantando continuamente con
le altre donne del villaggio dicendo che così morbidi e scorrevoli (al pettine)
loro non li avrebbero mai avuti.
KUL-DECKA,
come entrò e la vide, con la scusa di toglierle un pidocchio, glie ne strappò
una decina, li intrecciò e li lego alla punta del ramo.
Rimaneva solo da ricoprire l’amo. Dapprima pensò che avrebbe potuto utilizzare il pelo di Lepre o di un uccello
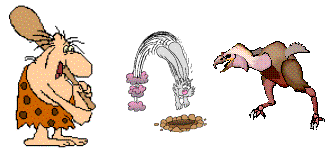
ma essendo un pessimo cacciatore non riuscì a rimediare nulla. Fu cosi che gli venne in mente, che, nei nidi d’anatra, spesso, assieme alle uova trovava delle piume molto morbide e leggere che avrebbero fatto al caso suo. Si diresse al nido che aveva appena depredato per fare colazione, raccolse un paio di piume, le legò con la treccia all’amo e quello che accadde subito dopo lo sappiamo dalle pitture rupestri pervenute fino ai giorni nostri.
